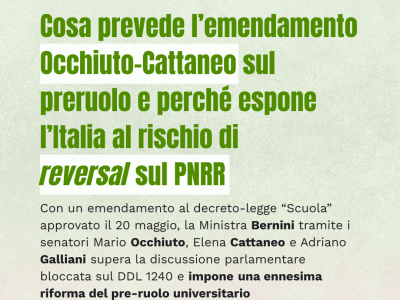
A fronte della paralisi della discussione parlamentare del DDL A.S. 1240, la cosiddetta “Cassetta degli attrezzi” della Ministra Anna Maria Bernini, come effetto delle proteste di questi mesi e degli esposti alle autorità europee di ADI e FLC, al Governo non resta che la decretazione d’urgenza per rendere ancora più precarie le vite di decine di migliaia di dottorandi e post-doc.
Il 20 maggio scorso, infatti, il Senato della Repubblica ha approvato una norma in materia di preruolo, il cosiddetto “emendamento Occhiuto”, dal nome del suo primo firmatario, il Senatore di Forza Italia Mario Occhiuto: si tratta della modifica n. 1.0.1 (corretto) al DDL n. 1445. Ciò è avvenuto senza la necessaria discussione parlamentare, tanto in commissione quanto in aula, con l’ipoteca della questione di fiducia posta dal Governo Meloni, in sede di approvazione del ddl n. 1445, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge n. 45/2025, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1) e l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026: si tratta del cosiddetto “Decreto Scuola” o “Decreto Valditara”. Come è evidente, in assenza di una vera discussione parlamentare e con le parti sociali, l’emendamento Occhiuto, con un colpo di mano, viene inserito surrettiziamente in un dispositivo di legge che non riguarda affatto l’Università.
Apripista per tale proposta emendativa, fortemente voluta dalla Ministra, è stato l’appello del 12 maggio scorso, in materia di dottorati Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), sottoscritto dai presidenti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’ANVUR, del CNR, della CoPER, della CRUI, dell’INFN e dal premio nobel prof. Giorgio Parisi, e inviato alla VII commissione del Senato, competente in materia di Università e Ricerca. L’emendamento vede tra i suoi firmatari anche la Senatrice a vita e Professoressa Ordinaria Elena Cattaneo, tra le principali voci del sostegno accademico alle politiche del Governo, e il Senatore Adriano Galliani. Il testo passa ora in seconda lettura alla Camera dei Deputati, dove verrà quasi certamente approvato nella sua versione attuale entro il 6 giugno 2025. Se non venisse approvato, infatti, cadrebbe l’impianto dell’intero Decreto Legge Valditara.
L’emendamento Occhiuto apporta modifiche alla L. 240/2010, la ben nota “Legge Gelmini”. Il testo inserisce, dopo l’articolo 22 (Contratti di ricerca), i nuovi articoli 22-bis (Incarichi post-doc) e 22-ter (Incarichi di ricerca), creando quindi due nuovi istituti accanto al contratto di ricerca, che ha di recente sostituito l’assegno di ricerca. Il Governo risolve quindi la “diatriba” sul pre-ruolo universitario inserendo nell’ordinamento giuridico non più quattro figure, come prevedeva la “Cassetta degli attrezzi”, ma due.
Incarichi post-doc
Gli incarichi post-doc entrano in rotta di collisione con i contratti di ricerca:
-
sono contratti a tempo determinato finanziabili sia su fondi interni che su fondi esterni (art 22-bis, co.1);
-
hanno durata minima di un anno e massima di tre (art 22-bis, co.2), con deroghe previste per lo schema di finanziamento Marie Curie (art 22-bis, co. 2);
-
sono riservati a chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca (art 22-bis, co.3);
-
sono finalizzati allo svolgimento non solo di attività di ricerca, ma anche di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione (art 22-bis, co.1).
Si tratta, a ben vedere, di una riproposizione in minore del vecchio RTDa, abolito dalla L. 79/2022, che prevede una retribuzione stabilita con decreto del Ministero, la quale – come per il contratto di ricerca –, non può essere inferiore al trattamento economico base dei ricercatori confermati a tempo definito (1500 euro al mese circa per 13 mensilità). Nella prima versione dell’emendamento si parlava addirittura, con esiti pesantemente distorsivi, di indennità e non di trattamento economico: alle indennità di accompagnamento, di frequenza, di disoccupazione si sarebbe aggiunta nel nostro Paese quella di ricerca. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, né con l’iscrizione a corsi di studio: una misura assurda quest’ultima, che non si comprende perché continui a essere inserita nelle leggi sul preruolo, anche a fronte della possibilità, prevista dall’ordinamento, della doppia iscrizione a corsi universitari (L. 33/2022). Dalla lettura del nuovo articolo 22-bis della L. 240/2010, in ogni caso, si evince che l’incarico post-doc, come il contratto di ricerca e a differenza dell’assegno di ricerca, dovrebbe qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le più importanti differenze rispetto al contratto di ricerca (ex art. 22 della L. 240/2010) sono le seguenti:
-
si richiede lo svolgimento anche di attività didattica e di terza missione;
-
si riducono la durata minima da 2 a 1 anno e la durata massima da 5 a 3 anni;
-
la determinazione del trattamento economico avviene per decreto (regime di diritto pubblico), diversamente dalla retribuzione prevista per il contratto di ricerca (regime di diritto privato), da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva (L. 240/2010, art. 22, co. 6).
Gli incarichi post-doc, quindi, non saranno meno onerosi dei contratti di ricerca. La ratio sottesa a questa norma non può dunque essere ricercata nella necessità di mettere a disposizione di rettori, direttori di dipartimento e professori uno strumento a più basso costo per inquadrare il lavoro di ricerca, in un sistema fortemente definanziato come quello italiano. Gli incarichi post-doc sono la manifestazione plastica del fatto che la canea di questi mesi de «il contratto costa troppo» fosse un mero pretesto per non darvi applicazione, pur rappresentando il contratto una milestone del PNRR. Tale relazione con i vincoli europei, in ogni caso, a differenza di quanto esternato dalla Ministra, non «inchioda il contratto al muro», non lo rende cioè immodificabile pro futuro qualora in sede applicativa si palesassero delle insormontabili rigidità. Se le difficoltà applicative del contratto fossero poi la durata minima biennale o la formula che lo vincola all’«esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca» (art. 22. co. 1), o ancora l’impossibilità di essere conferiti a vincitori di programmi di dottorato europei (es. Marie Curie), come denunciato dall’appello del gotha dell’accademia del 12 maggio, non si comprende perché si sia scelto di crearne, con un’innecessaria duplicazione, un fratellino minore, l’incarico post-doc, invece di intervenire su quelle fattispecie di supposta rigidità, come intendeva fare l’emendamento 4.0.3, a firma dei Senatori Verducci, D’Elia e Rando. Una nota dolente del contratto è chiaramente la didattica: venendo meno il carico di insegnamento di molti RTDa, specie PNRR, molti corsi di studio rischiano infatti di non rispettare i minimi requisiti ANVUR di docenza per l’accreditamento. Se infatti un contrattista di ricerca, a cui viene conferita una docenza a contratto (L. 240, art. 23) non concorre al computo per l’accreditamento, un incaricato post-doc sì, e ciò avviene senza un aumento della retribuzione mensile netta, come sarebbe invece auspicabile e come era previsto dall’emendamento Verducci-D’Elia-Rando. In ogni caso, tuttavia, nel quadro di un rapporto tra numero di docenti e studenti tanto desolante da far paventare addirittura la chiusura di interi corsi di studio, non si comprende perché la reazione dell’accademia italiana sia cercare una scappatoia, cioè gli incarichi, e non avanzare la richiesta di finanziamenti per l’unica posizione che de iure prevede carichi didattici: il ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).
È davvero tanto aberrante immaginare un sistema, non così lontano da quello che ha reclutato molti dei fautori accademici di questo emendamento, che preveda “solo” 9 anni di posizioni a tempo determinato: tre di dottorato e sei di RTT?
Ciò che sembra emerge, in ultima analisi, è una posizione ideologica, un’acredine esiziale – quasi antropologica – verso la contrattazione collettiva, l’unica fattispecie del contratto di ricerca di davvero complessa modificazione, la quale ha aperto per la prima volta alla sindacalizzazione della categoria dei ricercatori. La contrattazione è un punto non negoziabile: è garanzia di diritti e tutele. La contrattazione impedisce arretramenti e comporterà ciclicamente passi avanti, sia sul lato delle retribuzioni che delle tutele. Non sarà più possibile infatti avere gli stipendi fermi per più di un decennio, come è accaduto con l’assegno di ricerca, il cui ultimo decreto di adeguamento stipendiale risale al 2011 (D.M. 9 marzo 2011, n. 102): poco è importato se nel mezzo ci sono state guerre, crisi energetiche, pandemie e fenomeni inflattivi senza precedenti nella storia recente. Non sarà più possibile avere aumenti stipendiali che non coprono neanche l’inflazione, come è di recente accaduto anche con le stesse retribuzioni dei professori universitari, anche di quegli stessi ordinari che la contrattazione la aberrano.
Gli incarichi post-doc, dunque, vista l’esistenza del contratto di ricerca, non hanno alcuna ragion d’essere e innescano disparità sulle modalità di trattamento: ci troveremo infatti a lavorare fianco a fianco, nei laboratori, negli uffici, nelle biblioteche con colleghe e colleghi che faranno nella pratica esattamente il nostro stesso lavoro, ma avranno condizioni contrattuali diverse, chi da contrattista di ricerca, chi da incaricato post-doc.
Incarichi di ricerca
Veniamo dunque agli incarichi di ricerca, destinati a laureati da non più di sei anni, con il fine di «introdurli al lavoro di ricerca» sotto la supervisione di un tutor (art. 22-ter, co. 1): una condizione in cui non può trovarsi verosimilmente chi ha un dottorato di ricerca. Le modalità di conferimento di detti incarichi sono determinate da regolamenti locali (art. 22-ter, c. 2), ma ritorna un’inopportuna possibilità, già prevista per le borse di assistenza junior e senior del DDL 1240, ovvero l’inaccettabile conferimento diretto su fondi esterni (art. 22-ter, co. 4). Gli incarichi di ricerca possono durare da 1 a 3 anni, e il termine massimo è derogabile per le stesse ragioni dell’incarico post-doc di cui sopra (art. 22-ter, co. 7). Sul piano dell’inquadramento economico e giuslavoristico gli incarichi di ricerca non sono altre che degli assegni di ricerca sotto mentite spoglie: non prevedono IRPEF, IRAP e contributi in gestione pubblica, e hanno un trattamento economico minimo, stabilito con decreto del Ministro (art. 22-ter, co. 5). Quanto all’ambito previdenziale, ritorna l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, mentre si prevedono minimi avanzamenti in ambito di malattia e maternità.
Gli incarichi di ricerca avrebbero una ragion d’essere solo se ben perimetrati al pre-dottorato, come esito migliorativo delle attuali borse post-laurea. Peccato però che l’emendamento Occhiuto non abroghi tutti i riferimenti alle borse, ma solo quello all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210. Andrebbe invece soppresso anche il riferimento alle borse presente nell’art. 18 co. 5 lettera f della L. 240/2010. In ogni caso però, gli incarichi di ricerca, che possono essere conferiti fino a sei anni dalla laurea, si prestano, al pari delle stesse borse, a diventare un post-doc abusivo: se infatti un laureato inizia un dottorato di tre anni appena dopo la laurea, una volta dottore di ricerca potrà avere davanti a sé altri tre anni di incarichi di ricerca. Da sei anni si dovrebbe scendere almeno a quattro, com’era nella prima versione dell’emendamento.
Gli incarichi di ricerca sono generalmente incompatibili con la frequenza del dottorato, anche senza borsa, con una singola deroga: i dottorati Marie Curie. Con gli incarichi di ricerca si vorrebbe rispondere da vicino a un problema della massima urgenza: l’assenza di uno strumento contrattuale per i ricercatori impiegati all’estero che scelgono l’Italia per lavorare a un dottorato finanziato dal circuito Marie Curie (MSCA-DN), e non chi è già in Italia, che può accedere a tali finanziamenti solo in altri Paesi. Nonostante le dichiarazioni della Ministra sembrino implicare che anche i post-doc MSCA, tanto biennali quanto triennali (Global), non possano essere assunti con contratto di ricerca, lo stesso appello dei professori del 12 maggio, che spingeva a trovare una soluzioni per i dottorandi MSCA, ribadiva il principio che «il recente strumento del contratto di ricerca può essere impiegato per l’inquadramento dei vincitori delle Postdoctoral Fellowship». La stessa introduzione del contratto di ricerca nel 2022 rispondeva infatti a questa esigenza: gli assegni di ricerca, configurandosi come rapporto di collaborazione parasubordinato, non rispettavano né i criteri della Carta Europea dei Ricercatori, né gli standard Horizon e MSCA, e venivano conferiti ai post-doc in modo eccezionale. A ben vedere, tuttavia, neanche gli incarichi di ricerca rispetterebbero le linee guida dei dottorati MSCA: «As a rule, in MSCA DN projects, the beneficiary must recruit each eligible doctoral candidate under an employment contract or equivalent direct contract with full social security coverage (including sickness, parental, unemployment and invalidity benefits, pension rights, benefits in respect of accidents at work and occupational diseases)». Ancora una volta, e stavolta pericolosamente dopo la riforma della carriera dei ricercatori legata al PNRR, ci apprestiamo a varare uno strumento che funziona solo in regime di eccezionalità, e che ridurrà l’attrattività del Paese in Europa.
Gli incarichi di ricerca, dunque, sono uno strumento multiforme, mal congegnato, che si presta a innumerevoli abusi: possono essere conferiti prima e dopo il dottorato, nonché durante i dottorati ma solo se MSCA. L’incarico di ricerca dovrebbe limitarsi a sostituire le borse di ricerca per laureati, l’incarico post-doc dovrebbe cadere completamente a fronte del contratto di ricerca, e per i dottorati, tutti i dottorati, non solo quelli Marie Curie, in conformità con gli standard europei dovrebbe esistere un contratto di dottorato.
Quanto alle disposizioni relative alla spesa pubblica per l’attribuzione delle due nuove figure contrattuali, l’emendamento definisce, come fu per i contratti di ricerca, un tetto di spesa (art. 22-ter, co. 10): la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e la stipula dei contratti da RTDA, fatta salve le risorse finanziarie che provengono da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali sulla base di bandi competitivi. Si tratta di un’anomalia contabile che impedirà in futuro qualunque aumento del finanziamento ordinario per posizioni di ricerca, e anzi rischia di innescare una pericolosissima spirale deflattiva. Siamo di fronte dunque non solo di una riforma fatta a costo zero, ma anzi a un intervento che reca in sé già i semi di futuri tagli.
Il depotenziamento della tenure track
A differenza del DDL Bernini, infine, per tutte le forme di impiego antecedenti al Professore Associato, quindi incarico post-doc e di ricerca, contratto di ricerca e RTT, è posto un cumulo massimo di 11 anni, anche non consecutivi, rispetto ai 21 che si otterrebbero sommando la durata massima di ogni singola forma. Poiché però di per sé l’RTT può durare fino a 6 anni e non è possibile chiedere il passaggio ad associato prima del terzo anno, per evitare paradossali impasse, l’emendamento Occhiuto, aggiungendo un co. 3bis all’art. 24 della L. 240/2010, prevede che la durata della tenure track possa essere ridotta fino al minimo di un anno. Così, dunque, se oggi è possibile galleggiare in posizioni senza prospettiva di stabilizzazione per un massimo di 5 anni, con le nuove regole questo tempo sarà raddoppiato, dando sfogo a qualunque combinazione possibile, anche 3 anni di incarico di ricerca, 3 di incarico post-doc, 4 di contratto di ricerca e uno (sic!) da RTT (art. 3 bis). In questo schema, a ben vedere, non contano gli anni di assegno e di RTDa. Assistiamo a un autentico depotenziamento della tenure track, chiaramente presente anche nel recente schema di disegno di legge in materia di ASN e reclutamento.
È chiaro dunque che dietro la retorica della flessibilità contrattuale si celi l’esigenza - tutta politica - di moltiplicare le figure contrattuali, al fine di incrinare la tentata ricomposizione della classe ricercatrice precaria, operata dal contratto di lavoro di ricerca, e di tenere rinchiuse in un sistema definanziato quante più persone possibile per quanto più tempo possibile. Il rischio di esclusione dai fondi europei MSCA si riduce a mero spauracchio e anzi la toppa escogitata (incarico di ricerca) è peggiore del buco.
Per questi motivi, come ADI, chiediamo:
-
la soppressione dell’art. 1-bis della Proposta di modifica n. 1.0.1 (testo 2) al DDL n. 1445, nella fattispecie che introduce alla L. 240/2010 l’art. 22 bis (Incarichi post-doc);
-
in ordine agli incarichi di ricerca (art. 22-ter) l’abbassamento da «sei» a «quattro anni» dal conseguimento del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico (co. 1);
-
la soppressione del co. 4 sulle «procedure di conferimento diretto»;
-
la necessaria soppressione delle borse post laurea, con l’abrogazione di tutti i riferimenti normativi, in particolare dell’art. 18 co. 5 lettera f della L. 240/2010 («ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi»);
-
l’introduzione di un contratto di dottorato, che possa essere conferito a tutti i dottorandi in Italia, conforme alle linee guida del circuito MSCA-DN;
-
lo stralcio di tutti i riferimenti normativi ai «tetti di spesa» per l’assunzione di post-doc, tanto per gli incarichi quanto per il contratto di ricerca;
-
la salvaguardia e il finanziamento delle posizioni in tenure track, come strumento ordinario all’accesso a ruoli strutturati entro l’università italiana e l’estensione al contratto di ricerca di meccanismi di tenure, abrogando il co. 9 art. 22 della L. 240/2010 («I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»).
Ancora più preoccupante poi è il fatto che l’emendamento Occhiuto ostacoli la piena applicazione del contratto di ricerca, reintroducendo di fatto due figure prossime (se non coincidenti) con quelle abolite in vista del PNRR, l’assegno e l’RTDa. Tale fattispecie, già presente nel DDL 1240, aveva indotto ADI a presentare a febbraio un esposto alla Commissione Europea. Gli incarichi di ricerca, in particolare, risultano applicabili ai dottorati MSCA solo in deroga, dal momento che non si configurano come dei veri contratti di lavoro dipendente, come invece richiesto nel framework europeo. Non sembrano suffragate poi da fonti ufficiali le dichiarazioni del Governo sul fatto che l’emendamento Occhiuto fosse stato preventivamente condiviso con la task force PNRR della Commissione europea, che avrebbe fatto pervenire un preventivo giudizio di non incompatibilità, come riportato dall’ANSA, dal momento che è prassi che i controlli vengano fatti non a processo legislativo in corso, ma solo dopo la sua conclusione.
Per questo motivo, come ADI, ci troviamo di nuovo nella necessità di valutare, alla luce del testo approvato al Senato del DL Scuola, i possibili rischi non solo di reversal della riforma, in virtù del possibile aggiramento della milestone PNRR sulla carriera dei ricercatori, ma anche in generale di infrazione della normativa europea, dalla Carta Europea dei Ricercatori alla Direttiva (UE) 2024/1499, del 7 maggio 2024 sulla parità di trattamento economico.
Pubblicato Sab, 24/05/2025 - 18:14
- Accedi o registrati per inserire commenti.